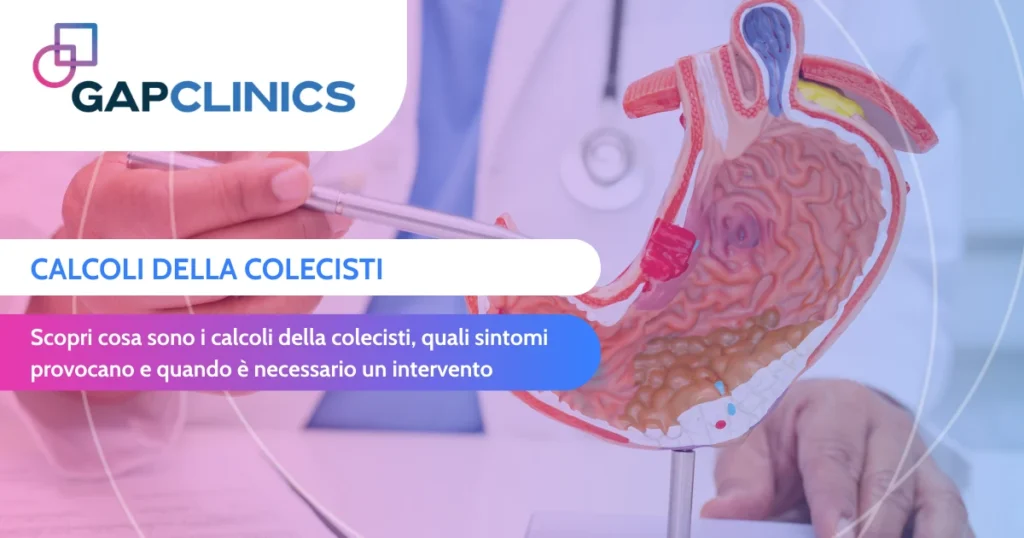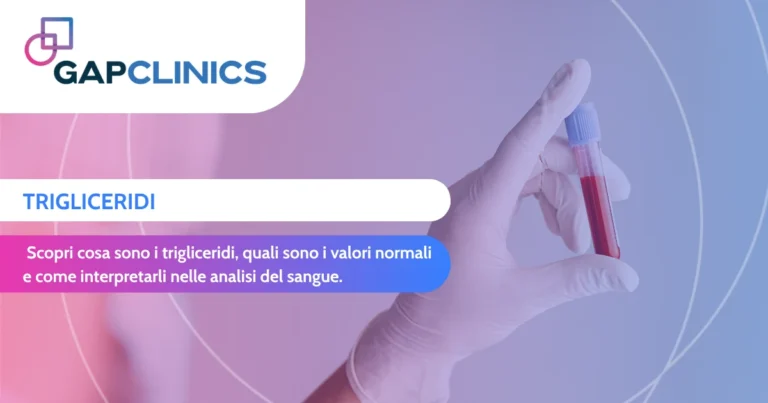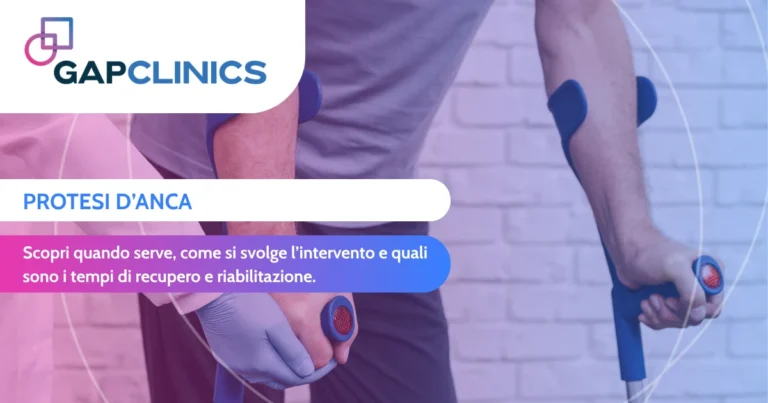Calcoli della colecisti: cause, sintomi, diagnosi e trattamento
I calcoli della colecisti, o colelitiasi, rappresentano una delle patologie più frequenti della colecisti, con un’incidenza crescente nei Paesi industrializzati. Si tratta della formazione di concrezioni solide all’interno della cistifellea, organo deputato all’immagazzinamento e alla concentrazione della bile, un fluido digestivo essenziale nella metabolizzazione dei grassi. Sebbene in molti casi la presenza di calcoli sia asintomatica, in alcune circostanze può determinare quadri clinici acuti che necessitano di trattamento urgente. La corretta diagnosi e l’approccio terapeutico tempestivo risultano fondamentali per prevenire complicanze anche gravi.
Che cos’è la colelitiasi
La colelitiasi è una condizione patologica caratterizzata dalla presenza di calcoli all’interno della colecisti. I calcoli sono formazioni solide costituite prevalentemente da colesterolo, pigmenti biliari (bilirubina) o una combinazione di entrambi. La loro genesi è legata a un’alterazione dell’equilibrio tra i componenti della bile, che porta alla precipitazione e successiva aggregazione di cristalli.
Esistono due principali tipologie:
Calcoli di colesterolo: più comuni nei Paesi occidentali, spesso associati a fattori metabolici e dietetici.
Calcoli pigmentari: composti da bilirubinato di calcio, tipici in condizioni emolitiche croniche o infezioni biliari.
La dimensione dei calcoli può variare da pochi millimetri a diversi centimetri e il loro numero può essere singolo o multiplo. La sola presenza di calcoli, tuttavia, non è di per sé indicativa di patologia attiva: molte persone convivono con calcoli asintomatici per tutta la vita.
Eziologia e fattori di rischio
La formazione dei calcoli biliari è un processo multifattoriale. La letteratura scientifica identifica diversi elementi predisponenti, sia genetici sia ambientali. L’alterazione della composizione biliare, la stasi della bile e l’infiammazione della parete colecistica rappresentano i tre meccanismi fisiopatologici principali.
Tra i fattori di rischio più documentati:
Sesso femminile: a causa dell’influenza estrogenica sull’epatobiligenesi.
Età avanzata: l’incidenza aumenta con l’età, in particolare dopo i 40 anni.
Obesità e sindrome metabolica: l’eccesso di massa grassa influisce sulla sovrasaturazione di colesterolo nella bile.
Dieta ipercalorica e povera di fibre: aumenta il rischio di colelitiasi.
Perdita di peso rapida: come in seguito a diete drastiche o interventi bariatrici.
Gravidanza: la variazione ormonale può rallentare lo svuotamento della colecisti.
Familiarità: componente genetica dimostrata.
Sintomatologia: quando i calcoli diventano clinicamente rilevanti
La maggior parte dei calcoli resta asintomatica e viene identificata incidentalmente in corso di indagini ecografiche per altri motivi. Tuttavia, in circa il 20–30% dei casi, la colelitiasi può evolvere verso manifestazioni sintomatiche o complicanze.
Il sintomo cardine è la colica biliare, caratterizzata da dolore acuto, spesso descritto come un peso costrittivo localizzato in ipocondrio destro, talvolta irradiato alla scapola destra o alla schiena. Il dolore insorge tipicamente dopo pasti ricchi di grassi e può essere accompagnato da nausea, vomito, senso di digestione difficile e sudorazione.
Quando si associano febbre, leucocitosi e segno di Murphy positivo, si sospetta la progressione verso colecistite acuta. Altri quadri clinici associati comprendono:
Colangite acuta: infezione delle vie biliari con triade di Charcot (febbre, ittero, dolore).
Pancreatite acuta biliare: causata da migrazione litiasica nella papilla di Vater.
Ittero ostruttivo: da occlusione del dotto coledoco.
Diagnosi: strumenti e criteri
L’iter diagnostico si basa su un approccio integrato tra anamnesi, esame obiettivo, esami di laboratorio e diagnostica per immagini.
L’ecografia addominale è l’indagine di prima scelta per la valutazione della colelitiasi: è non invasiva, priva di radiazioni e ad alta sensibilità nel rilevare calcoli e ispessimento parietale della colecisti. In presenza di segni indiretti di complicanza, si può ricorrere a indagini di secondo livello quali:
Colangio-RM (MRCP): per visualizzare le vie biliari in modo dettagliato.
Ecoendoscopia: utile in caso di litiasi di piccole dimensioni non evidenti all’ecografia.
ERCP (colangiopancreatografia retrograda endoscopica): indicata a scopo terapeutico per l’estrazione di calcoli nel coledoco.
TAC addome: indicata nei casi dubbi o per escludere complicanze come perforazioni o ascessi.
Gli esami ematochimici (transaminasi, bilirubina, fosfatasi alcalina, amilasi/lipasi, leucocitosi) aiutano a definire il grado di infiammazione e l’eventuale coinvolgimento pancreatico o epatico.
Trattamento: approccio conservativo e chirurgico
Terapia medica
In pazienti asintomatici, si predilige un atteggiamento osservazionale. In soggetti non candidabili alla chirurgia, il trattamento medico si basa su:
Regimi dietetici poveri di grassi e bilanciati.
Acido ursodesossicolico: utile nei calcoli di colesterolo <1,5 cm e colecisti funzionante, ma con tasso elevato di recidiva.
Antispastici e analgesici durante episodi colici.
Terapia chirurgica
La colecistectomia laparoscopica rappresenta il trattamento di elezione nei pazienti sintomatici. È una procedura mini-invasiva che prevede la rimozione completa della colecisti tramite accessi millimetrici. I vantaggi includono:
Ridotta degenza post-operatoria.
Minore dolore.
Rapida ripresa funzionale.
L’intervento è indicato:
In presenza di coliche ricorrenti.
In caso di colecistite, pancreatite o colangite.
In pazienti a rischio di complicanze (es. immunodepressi, portatori di polipi >10 mm).
Nei pazienti fragili o non operabili, si possono considerare alternative temporanee come il drenaggio percutaneo della colecisti sotto guida ecografica.
Dieta, prevenzione e follow-up
Sebbene la dieta non sia curativa, una corretta alimentazione può contribuire a ridurre il rischio di formazione o di ricomparsa dei calcoli. Un’alimentazione equilibrata dovrebbe privilegiare grassi insaturi, fibra alimentare e un buon apporto idrico quotidiano.
In soggetti sottoposti a colecistectomia, il fegato continua a produrre bile, ma questa viene riversata direttamente nell’intestino. È dunque consigliato adottare un regime alimentare che eviti pasti ricchi di grassi saturi e favorire pasti piccoli e frequenti.
Il follow-up post-operatorio si basa su controlli clinici e monitoraggio degli esami ematici. In caso di litiasi residua delle vie biliari, si può ricorrere a ERCP terapeutica.
In che modo GAPCLINICS può fornirti il supporto di cui hai bisogno
I calcoli della colecisti costituiscono una condizione clinica frequente, spesso sottovalutata, ma potenzialmente responsabile di complicanze severe. La corretta identificazione del quadro clinico, una valutazione multidisciplinare e una gestione tempestiva rappresentano elementi fondamentali per la buona riuscita terapeutica.
Presso GAPCLINICS, il paziente può contare su un percorso diagnostico-terapeutico completo, che include consulenze specialistiche in gastroenterologia, diagnostica per immagini ad alta definizione e supporto chirurgico qualificato. La prevenzione delle complicanze e la personalizzazione del trattamento restano gli obiettivi principali di un approccio clinico moderno ed efficace.